Questo saggio proviene dal ventitreesimo volume de La Ragione Critica, «CON ANGELICA VOCE…» Studi in onore di Rosario Scrimieri Martín, edito nel 2023 per Ledizioni. Ringraziamo autore ed editore per la gentile concessione.
1.
Nell’ultimo cinquantennio l’allegoria ha goduto di una generale ripresa, di un clima favorevole e del superamento delle vecchie remore estetiche che l’avevano relegata in subordine. Sarà per l’affermazione mondiale del pensiero di Walter Benjamin che ne è stato cultore in anni di basse stime; sarà per un certo tono decostruzionista che ha marcato un periodo della teoria letteraria, sarà per il clima postmoderno improntato alla riscrittura e all’artificio, fatto sta l’allegoria è tornata pronunciabile nel discorso teorico e critico. Aggiungerei: fin troppo. Perché l’accoglimento indiscriminato ha ingenerato non pochi equivoci. La stessa nozione di allegoria ne è risultata oltremodo semplificata, ridotta a un rimando generico. Si vedono allegorie dappertutto e non si tratta altro che di quel “senso” complessivo che non si può negare a nessuna opera, comunque sia organizzata, sicché non è più possibile stabilire la differenza addirittura con il realismo (l’allegoricità del realismo sarebbe semplicemente ciò che significa per noi a distanza di tempo), per non parlare della differenza rispetto al simbolo: tranquillamente, autori prima guardati con lenti simboliche vengono ora convertiti in allegoristi.
Tra le fonti di equivoci c’è anche la mancata distinzione tra l’allegoria tradizionale e l’allegoria moderna. L’allegoria ha infatti una lunga storia ed è una pratica antica sia di interpretazione che di creazione. Nel passato il suo uso didattico-morale prevedeva che fosse facilmente decodificabile in base a una iconologia condivisa. Si può dire che l’allegoria tradizionale sia una allegoria “con la chiave”. La perdita della chiave è ciò che costituisce l’allegoria moderna: un caso eclatante lo potremmo trovare in Kafka, dove l’allegoria è, per così dire, aperta a una serie di soluzioni (compresa quella – da alcuni polemicamente asserita – che non ci sia per nulla un secondo senso).
Si comprende subito che l’allegoria “senza chiave” si libera dell’accusa di convenzionalità, che invece ha ragion d’essere nei confronti dell’allegoria tradizionale. E si libera anche dell’accusa di univocità, che era stata avanzata soprattutto nel confronto con il simbolo, contrapponendo all’allegoria subito risolta un simbolo inesauribile. Addirittura le parti si ribaltano: l’allegoria “senza chiave” diventa polisensa, mentre è il simbolo ad apparire univoco perché, se è un rimando immediato, è la prima cosa che viene spontaneamente in mente…
Una interessante distinzione è quella proposta da Fredric Jameson nel suo recente Allegory and Ideology (Jameson 2019) che raccoglie e riorganizza una riflessione che viene da lontano, passata attraverso L’inconscio politico, il volume sul postmodernismo, Brecht e il metodo (1) e concentrata ora sulla differenziazione tra allegoria e personificazione. Le due, allegoria e personificazione, sono facilmente confondibili e spesso effettivamente confuse. Eppure corrispondono a procedimenti diversi e sostanzialmente opposti: nella personificazione incontriamo un essere che porta il nome di una entità astratta, designata per solito con la maiuscola, il Tempo, la Verità, ecc.; quindi non vi è alcun dubbio sui ciò che il personaggio rappresenti. Invece nell’allegoria incontriamo qualcosa che non corrisponde ad una rappresentazione mimetica (che so, la tigre di Blake che salta fuori dalle “foreste della notte”): allora dobbiamo interpretare questa presenza enigmatica e correlarla alle altre che eventualmente l’accompagnano (di solito l’allegoria è contagiosa). La confusione può essere ingenerata dalla pittura, in cui le due pratiche sono intrecciate – si può trovare una donna che ha i serpenti per capelli e accanto il cartiglio che dice “Invidia”, – lì l’enigma dell’allegoria è sciolto dalla personificazione.
L’iconografia classica non è altro che un catalogo di personificazioni. Jameson inizia con un sentito elogio dell’allegoria, della sua natura problematica che sollecita discussione e apre prospettive critiche. L’allegoricità dell’allegoria:
“It does not seem wise to begin our presentation with the secret that allegory is itself allegorical: an interpretive virus that, spreading by way of its own propagations, proliferates and perpetuates itself until, in a kind of incurable interpretive frenzy, it becomes indistinguishable from the text and no longer visible to the naked eye. Yet allegory is also a surgical instrument and a diagnostic tool, by way of which the atomic particles of a sentence or a narrative, the most minute meanings and secondary connotations, are registered on the X-ray plate in all their guilty absence, in all their toxic participation” (Jameson 2019: 1).
Immediatamente dopo viene citata l’interpretazione dei sogni da parte di Freud ed è allora subito chiaro che questo allegorismo non ha certezze e si esercita proprio sul testo meno comprensibile, quello che non quadra e che quindi ci chiama al compito di interpretarlo. Così l’allegoria lascia il salvagente della convenzione e si mette in braccio al polisenso (non a caso un capitolo del libro jamesoniano, il più innovativo in assoluto, è dedicato all’allegoria in musica). Là dove si trova una immediata corrispondenza tra un segno e un senso (un segno, cioè, subito traducibile in un secondo significato), lì siamo ancora nell’ambito di una configurazione arretrata: «The two-level system is the mark of bad allegory» (Jameson 2019: 6); mentre di contro «We may then also draw the provisional consequence that genuine allegory does not seek the “meaning” of a work, but rather functions to reveal its structure of multiple meanings, and thereby to modify the very meaning of the word meaning» (Jameson 2019: 10).
Ora, in questo avversato “sistema a due livelli”, che Jameson chiama anche “dualistic” e “point-to-point”, rientra innanzitutto la personificazione in cui noi – avvertiti dalla maiuscola del nome – non facciamo nessuna fatica a passare dal personaggio alla nozione che rappresenta. Ma ugualmente vi rientra la metafora e perfino (sorprendentemente) il simbolo. Il simbolo, che i romantici avevano valorizzato come momento della autenticità intuitiva e della infinita rivelazione, appare in questa prospettiva legato alla nostalgia di un “testo sacro” (magari della natura) come garanzia del suo rimando. Dall’altra parte, Jameson non fa neanche tanto riferimento alla modernità nelle sue punte più radicali e avanzate, ma parte – come già altra volta, ne L’inconscio politico – dalla ripresa della dottrina dei 4 sensi, medievale e dantesca. Un’allegoria fourfold è già passata nell’ambito della molteplicità. Certo, i 4 livelli vengono riformulati con l’apporto della psicoanalisi, del marxismo e della semiotica (coincidendo il numero 4 con i lati del quadrato semiotico greimasiano(2)); e non c’è una semplice scala elevativa dal basso all’alto, quanto piuttosto sono considerati significativi, nelle specifiche letture che il libro compie, i contrasti tra i livelli e le “transizioni” dall’uno all’altro. In buona sostanza si teorizza un allegorismo dove sono più importanti le relazioni che non i nomi, e dove vengono contemplate come necessarie la complessità e la contraddizione. Fino a dire che
“modern allegory involves a kinship between processes, unlike the personifications of classical or traditional allegory: it is the interechoing of narratives with one another, in their differentiation and reidentification, rather than the play with fixed substances and entities identified as so many traits or passions, for example, incarnated in individual figures all the way to the caricatural or the stereotypical. We will find ourselves reverting again and again to this insight: that it is the disappearance of personification that signals the emergence of modernity” (Jameson 2019: 48).
La personificazione potrebbe ribattere al decreto di espulsione che proprio in questa nuova impostazione essa può rientrare a certe condizioni nell’insieme dei “contro-canti”. Magari costituendo un’immagine dubbia come, per avanzare intanto a mia volta un esempio, nel IV Spleen di Baudelaire, l’Angoscia che «atroce, despotique, / sur mon crâne incliné plante son drapeau noir»: un’immagine che – oltre alla espressione carica di crudeltà e spossessione – presenta vari problemi, per così dire, di “visualizzazione” (come è fatta l’Angoscia? quanto è grande per stare sopra una testa? quanto fa male l’asta della sua bandiera? – ecc.).
Se l’allegoria si riconosce dall’irrealismo della rappresentazione, se è qualcosa di incoerente rispetto alla verosimiglianza mimetica, se la sua non autosufficienza, come ha sottolineato lo stesso Jameson nel suo volume brechtiano, è come un’“apertura” o una “ferita nel testo”(3), la modernità radicale comporta un di più. Teste Benjamin, è decisiva la frammentarietà, l’insieme composito, eterogeneo, ibrido; e di conseguenza la disarmonia, la contrapposizione e la “ribellione degli elementi”. I testi dell’avanguardia – al pari del mondo onirico interrogato da Freud – presentano all’interprete uno strano problema: si tratta di strappare un senso a ciò che non ne ha, a ciò che si presenta volutamente oscuro e irridente alla “buona volontà” della comprensione ermeneutica. Perduta la chiave, l’allegoria appare vuota, ma è pur sempre un appello alla ricerca. Forse un’allegoria del vuoto, un’allegoria del nulla, come ebbe a dire Lukács «il mondo come allegoria di un trascendente nulla» (Lukács 1978: 901) cercando di screditare negativamente Kafka insieme allo stesso Benjamin.
L’allegoria moderna appare figlia del negativo, della crisi per cui i miti e i simboli decadono dai loro piedistalli e in generale le figure mimetiche perdono senso divenendo disponibili ad assumerne un altro (allon agoreuo). Allegoria del fallimento storico, così l’ha configurata Walter Benjamin a partire dal “barocco tedesco”:
“Mentre nel simbolo con la trasfigurazione della caducità fuggevolmente si rivela il volto trasfigurato della natura nella luce della redenzione, nell’allegoria si propone agli occhi dell’osservatore la facies hippocratica della storia come un pietrificato paesaggio primevo. La storia in tutto quanto ha, fin dall’inizio, di inopportuno, di doloroso, di sbagliato, si configura in un volto – anzi: nel teschio di un morto” (Benjamin 1971: 174).
Una negatività che si imprime anche nelle immagini: «La falsa apparenza della totalità si spegne», scrive ancora Benjamin, «l’eidos si oscura, la similitudine viene meno, e il cosmo, in ciò, s’inaridisce» (Benjamin, 1971: 186). Spesso l’allegorismo novecentesco si annida in un simile guastarsi dell’immagine; l’immagine dovrebbe essere un momento felice di uscita – o comunque di miglioramento – dalle e delle brutture della realtà, e invece la sua funzionalità di “rappresentante altro” la riattira nel livello del caduco e del transeunte. L’immagine s’oscura: non è più arricchimento, quanto piuttosto problematizzazione – e desublimazione. Questo tipo di allegoria potrebbe essere verificato in tutte le arti; per intanto qui di seguito compirò un rapido passaggio su alcuni casi significativi della poesia italiana del Novecento.
2.
Il primo campione lo prendo dai Canti orfici di Dino Campana. Campana è una figura anomala nel quadro fortemente radicalizzato del primo Novecento letterario; è tangente alle avanguardie futuriste e vociane, ma senza confondersi in esse, ha una propria cifra “musicale e colorita”, come dice egli stesso, riconosciuta come alterazione visionaria, onirica, pittorica. Come impianto, però, la sua poesia sembra partire da una base di luoghi riconoscibili (italiani, sudamericani, ecc.) attraversati da un soggetto nomade che li ricompone nel sogno («Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno») (Campana, 1973: 310) (4). Nel paesaggio trasfigurato dal ricordo si insinuano però le torsioni del negativo, come vediamo proprio in partenza dei Canti, nelle prime battute de La Notte:
“Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso” (Campana, 1985: 15-16).
La città reale si trasforma in una dantesca città infernale, lo spazio si dilata in ampiezza (la pianura è “sterminata”, gli archi del ponte sono “enormemente vuoti”), il che rimanda nella lontananza le stesse presenze umane, ridotte a “sagome” e a “forme”. Tali presenze sono poi zingari/e, cioè occupanti solo provvisori del territorio. Il loro canto è “primordiale”, il che prelude alla sentenza finale della “sospensione del tempo”, tuttavia anche “irritante”, un attributo che rimane inspiegato (irritante a causa della monotonia? Irritante per chi?). La scena è dominata dall’arsura, solo poco compensata dal “refrigerio” delle colline. Insieme al tempo, anche la rappresentazione pare sospesa nelle sue antitesi: arsura/refrigerio, territorio/esilio, mutismo (la “palude afona”)/suono continuo (la “nenia monotona”). Vi si potrebbe trovare la benjaminiana “Dialektik im Stillstand”, dialettica in stato di stallo. Il senso si compone da una complessa “costellazione” di significati. Qui l’allegorismo include il mito con la “barba giudaica” propria dell’ebreo errante, un ulteriore stigma nomadico.
Saltando alla fine dei Canti orfici, con Genova troviamo un paesaggio urbano addirittura esplicitamente nominato. Ma la città, qui, ha la caratteristica di una prospettiva digradante che assume una accelerazione “discenditiva”, quasi un crollo («Dilaga la piazza al mare… Come le cateratte del Niagara») (Campana, 1985: 318); che termina nel porto, quindi nella prospettiva di un territorio aperto, disponibile alla partenza verso l’altrove. E infatti è percorso da viaggiatori, non tanto curiosi turisti, quanto necessitati emigranti: «Ombre di viaggiatori / Vanno per la Superba / Terribili e grotteschi come i ciechi» (Campana, 1985: 326) – dove, oltre alla cecità breugheliana, c’è la riduzione a “ombre” che mi ricorda La chimera, «l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti», (Campana, 1985: 76) (5) con una sorta di evanescenza, di fantasmatizzazione del “materiale umano”. Il lavoro, per altro, si presenta nel porto in forma impersonale attraverso i rumori inquietanti e assolutamente dissonanti delle barche, che indicano una sorta di continua e ininterrotta funzione della macchina produttiva: «Il battello si scarica / Ininterrottamente cigolante, / Instancabilmente introna» (Campana, 1985: 324).
Intorno alla metà di questo componimento, fatto di parti prese da diversi abbozzi e montate insieme, c’è un innalzamento che corrisponde ad un’acme visionaria: la “visione di grazia”, per l’appunto: .
.jhgh
Quando,
Melodiosamente
D’alto sale, il vento come bianca finse una visione di
Grazia
Come dalla vicenda infaticabile
De le nuvole e de le stelle dentro del cielo serale
Dentro il vico marino in alto sale, ……….
Dentro il vico chè rosse in alto sale
Marino l’ali rosse dei fanali
Rabescavano l’ombra illanguidita, ………..
Che nel vico marino, in alto sale
Che bianca e lieve e querula salì!
«Come nell’ali rosse dei fanali
Bianca e rossa nell’ombra del fanale
Che bianca e lieve e tremula salì:…» —
Ora di già nel rosso del fanale
Era già l’ombra faticosamente Bianca ………..
Bianca quando nel rosso del fanale
Bianca lontana faticosamente
L’eco attonita rise un irreale
Riso: e che l’eco faticosamente
E bianca e lieve e attonita salì ………
.
(Campana, 1985: 321-322)
Quello che negli abbozzi era l’incontro con una fanciulla («L’apparizione fu ineffabile / Una grazia lombarda» (Campana, 1973: 348) diventa un’immagine evanescente prodotta dalla natura (il vento salmastro, l’«alto sale») che viene grado a grado coinvolta nel mero colore (il gioco del bianco e del rosso) e nella variazione continua che passa anche per una versione tra virgolette e in corsivo, quasi che il testo citasse se stesso… Ma cosa significa ripetere? È un modo di evidenziare? È un trasformare in elementi musicali? O non significa piuttosto non riuscire ad esprimere? Insomma, il punto culminante dell’apparizione (il momento simbolico) finisce nel balbettio. O nel gioco di parole, come quel bisenso «alto sale»…
La chiusa del testo viene dedicata a una apparizione esattamente contraria, quella di una prostituta, inquadrata da una finestra. La sublimazione dell’amore viene così riportata a terra, alla vendita del corpo, che poi sottolinea la spietatezza sociale, lo sfruttamento come sfruttamento dell’intera vita. Ma c’è di più, nel gioco dell’ombra e della luce nei «cavi vetri»: .
O Siciliana proterva opulenta matrona
A le finestre ventose del vico marinaro
Nel seno della città percossa di suoni di navi e di carri
Classica mediterranea femmina dei porti:
(…)
Ch’era la notte fonda.
Mentre tu siciliana, dai cavi
Vetri in un torto giuoco
L’ombra cava e la luce vacillante
O siciliana, ai capezzoli
L’ombra rinchiusa tu eri
La Piovra de le notti mediterranee.
Cigolava cigolava cigolava di catene
La grù sul porto nel cavo de la notte serena:
E dentro il cavo de la notte serena
E nelle braccia di ferro
Il debole cuore batteva un più alto palpito: tu
La finestra avevi spenta:
Nuda mistica in alto cava
Infinitamente occhiuta devastazione era la notte tirrena
.
(Campana, 1985: 328-330)
Marcello Carlino, che dell’allegoria in Campana si è occupato in molteplici occasioni, così commenta: «È un divenire piovra, quello della siciliana, che si mostra di segno allegorico; e che trova un’altra esposizione allegorica nella sagoma meccanica – che ha qualche somiglianza con quella della piovra –, nello scheletro di una gru». (Carlino, 2008: 166) La piovra cresce di dimensioni fino a corrispondere alla notte stessa, l’attributo “occhiuta” fa sì che le sue ventose diventino occhi, e occhi di controllo del mondo; mentre le «braccia di ferro» della gru si chiudono in un abbraccio invero costrittivo, accompagnato dal rumore reiterato (in stridente disturbo) delle «catene». La notte è «nuda», non tanto come richiamo erotico, ma piuttosto come svelamento della “infinita devastazione”, ed è «mistica». Sono convinto che qui non si tratti di “misticismo” come intuizione spirituale, bensì del significato secondo che anticamente (vedi Clemente Alessandrino) (Zambon F., 2021: 58, 79) veniva indicato appunto come “mistico”. Intendere “mistico” per “allegorico”. Una allegoria della devastazione.
3.
Inoltrandoci nel Novecento, un’altra importante figura è Eugenio Montale. Importante perché Montale si trova ad agire in un periodo di riflusso, nel primo dopoguerra e nel ventennio fascista, smorzata la spinta propulsiva delle avanguardie, tra segnali di ritorno all’ordine. In quella “terra di mezzo” si andrà configurando la lingua poetica dell’ermetismo, che resiste ancora oggi come “senso comune poetico italiano”. Ciò spiega la difficoltà che ha avuto la critica nel distinguere, in Montale, simbolo e allegoria. E, a ben vedere, lo stesso autore a districarsi, per stare nella sua prima e decisiva raccolta, gli Ossi di seppia, tra evenienze impalpabili e apparizioni sfuggenti (come in Cigola la carrucola del pozzo o in Vasca) e sensi secondi ancora in qualche modo legati alla allegoria tradizionale.
Ad esempio, Meriggiare pallido e assorto è impiantato su una situazione tipica della lirica, il viandante solitario nel paesaggio naturale, anche se il “pallido e assorto” montaliano non sembra avere le pena d’amore del “solo e pensoso” di Petrarca. E il paesaggio, naturalmente, è il famoso ambiente ligure, caratterizzato dall’aridità, qui intensificata dall’ora meridiana che surriscalda il muro («presso un rovente muro d’orto»). Queste le prime tre quartine: .
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
.
(Montale, 1980: 28)
Abbiamo dunque un passeggero concentrato in sé («assorto») e tuttavia molto attento con le antenne dei sensi – i verbi delle prime tre strofe sono: ascoltare, spiare, osservare – a cogliere il minimo segnale (si rivolge al mondo “minuscolo” delle formiche, al verso “tremulo” delle cicale) proveniente dalla natura. Solo che la natura rende soprattutto sonorità consonantiche sgradevoli: ecco le “rime aspre e chiocce”, quali sterpi/serpi, scricchi/picchi (proprio dantesca, questa) e in generale le emergenze inquietanti sia a livello dell’udito (schiocchi, frusci) che a livello visivo (crepe del suolo, scaglie di mare).
Comunque, fin qui il testo procede con un taglio percettivo ed è riportabile all’aneddotico-realistico (ho fatto un giro e ho udito/visto questo e quello). Ma c’è una strofa ulteriore che si distingue dalle precedenti sia come numero di versi che come rima: i versi sono 5 e la rima è una sola, però imperfetta, restando costante la laterale palatale “gl” (già preparata dalle «scaglie»), che rende anch’essa una sonorità piuttosto complicata: .
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
.
(Montale, 1980: 28)
La sua forma particolare sembra sottolineare anche un tono diverso, quello di una spiegazione, o comunque di una riflessione interiore, giustificata per altro, in partenza, dalla concentrazione dell’“assorto”. Lo stesso verbo sentire è generico, ma percettivo la sua parte, il che farebbe supporre un rimando intuitivo, più simbolico che allegorico. Il senso della scena, però, Montale decide di esplicitarlo per bene, con una completa metafora, quindi proprio con un rapporto biunivoco che dice: la vita è una muraglia invalicabile. Non è detto che il termine di paragone sia, per così dire, metonimico, cioè che la «muraglia» provenga da quel «muro d’orto» iniziale, però ormai distanziato nella passeggiata dell’io lirico – che poi neanche è detto sia un “io”: gli infiniti (meriggiare, ascoltare, ecc.) restano aperti a diverse possibilità. In ogni caso, le percezioni precedenti diventano le avvisaglie di questa sentenza che figura un po’ come il cartiglio delle allegorie pittoriche tradizionali. Tuttavia c’è qualche complicazione. Negli Ossi, a partire da In limine, c’è il problema del varco, del superamento dell’«erto muro», ma in Meriggiare, applicato alla vita, suona come non del tutto tradizionale. Nell’immagine usuale l’insensatezza della vita è rappresentata dalla morte, è perciò semmai un “abisso orrido, immenso” non un muro difficile da scalare. Non della vita, dunque, si tratta, ma del “senso della vita”: il muro protettivo – propriamente caratteristico della paranoia proprietaria – dice quindi che il senso non si raggiunge; e già il «sole che abbaglia» connota una visione impedita. L’allegoria, per quanto semplice, ha dunque già un risultato zero.
È quanto ribadisce in modo più compiutamente moderno Forse un mattino andando in un’aria di vetro: .
Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore da ubriaco.
Poi, come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto
alberi, case, colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
.
(Montale, 1980: 40)
Qui ogni aneddoto è abbandonato, la poesia non riguarda un ricordo del passato, ma una ipotesi, per altro molto incerta: «Forse». Non è detto… Non è neanche l’ottativo che si trova in altri Ossi (il «suonasse te pure» di Corno inglese). Non c’è testimonianza dell’evento, il tempo è al futuro: vedrò, s’accamperanno, me ne andrò. E l’evento, poi: il “miracolo” sarebbe esattamente la manifestazione del senso rivelato, insomma del simbolo. Ma, come ha scritto giustamente Rosario Scrimieri nel presentare la traduzione in spagnolo di Montale, qui si tratta di «éxtasis “invertido”» (Scrimieri, 1996: 15). Non promette nessuna soddisfazione di pienezza, ma al contrario svela il negativo del «nulla» e del «vuoto».
Qui l’io non s’introverte, “assorto”, nella riflessione interiore, né pronuncia sentenze definitorie (il senso della vita è…), ma è la stessa allucinazione visiva (vedrò…) a disperdere il mondo delle percezioni. A differenza di Meriggiare, inoltre, non abbiamo il nulla del senso che non si può raggiungere, ma il senso si raggiunge ed è il nulla. Allegoria del nulla? Juan Carlos Rodríguez, in un suo commento, ha riportato questa scoperta del “vuoto” alla condizione della scrittura: «Montale es taxativo, es genial. […] Eso es lo que la escritura de hoy ve, descarnadamente, con un “terrore di ubriaco”. Ese terror ebrio, de borracho, es en efecto la necesidad de escribir con la nada» (Rodríguez, 2002: 55). Già all’inizio quell’«aria di vetro» era magistralmente ambigua: indica la trasparenza, in primo luogo, ma se forzassimo la metafora, ci sarebbe un vetro, un diaframma tra noi e le cose: e infatti, di seguito, c’è lo «schermo», forse cinematografico, ma prefigurante tutti gli schermi in cui siamo inclusi, fino allo smartphone, uno schermo che contiene insieme le cose naturali e le umane, «alberi, case, colli» (l’abitazione inglobata nel paesaggio). L’inganno non è semplicemente l’apparenza, è la stessa realtà. Negazione radicale prodotta da un gesto sembrerebbe involontario: girarsi, “rivolgersi”, “voltarsi” – e si potrebbe, credo, associarvi la rivolta. “Miracolo”, insomma, non benefico, che porta al terrore, alla perdita di equilibrio, e segna chi ne è toccato con la solitudine del “segreto”.
[E]d io me n’andrò zitto / tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto»: chiude sull’aporia del non lo dirò / lo sto dicendo… Ma più probabilmente è un modo per sottolineare la temporalità della scrittura e dell’allegoria stessa: scrivere è consegnare un segreto al lettore futuro, e in questo caso gli commette anche l’esortazione a cercare di “rivoltarsi”.
4.
Passando al secondo Novecento, possiamo aspettarci un’ulteriore complicazione dell’allegorismo, soprattutto nella fase delle nuove avanguardie sperimentali. In tal senso l’esempio di Amelia Rosselli risulta calzante, perché nel suo caso il peggioramento dell’immagine (l’inserimento del disforico nell’euforia dell’immaginazione) viene perseguito con una forte accentuazione della rapidità. Nel gioco delle variazioni – e sono, quelle di Amelia Rosselli, fin dal titolo complessivo, precisamente Variazioni belliche – nessun “tono” riesce a rimanere saldo, senza essere trascinato a un di presso verso il contrario, tanto che si potrebbe parlare di una “sintassi dell’ossimoro”. Diversamente dalla “negazione della comunicazione” caratteristica di un certo sperimentalismo di quel tempo, Amelia Rosselli muove dalla fiducia nella spontaneità dell’immaginazione: senonché, altrettanto spontaneamente, le immagini “positive” (portatrici di valori di pienezza e di felicità), talmente investite di senso come sono, non reggono al peso e si ritrovano perciò – solo un attimo dopo – oscurate e caricate di connotazioni “negative”. Nessuna immagine resiste a questo “ritmo sterminatore”. Vediamo qui il testo che chiude la sezione delle Variazioni (1960-61): –
Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora
tutto il mondo è vedovo se è vero! Tutto il mondo
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il
mondo è vedovo se tu non muori! Tutto il mondo
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi
dalla tua nascita e l’importanza del nuovo giorno
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono
ché tu cammini ancora! cieca sono che tu cammini
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. .
(Rosselli, 2012: 179)
La struttura di questa poesia presenta ripetizioni di interi blocchi con minime variazioni: «tutto il mondo è…», «se tu cammini», «cieca sono»… Da un lato queste sequenze reiterate servono a garantire il ritmo del testo; si tenga conto che la Rosselli adotta una metrica rigorosamente “spaziale”, ossia legata non al numero delle sillabe, ma allo spazio disponibile nella pagina (come teorizza nel suo scritto di poetica Spazi metrici); quindi per distinguere il testo poetico dalla mera prosa, la ritmicità deve essere assicurata per un’altra via, che è quella delle strutture sintattiche. Ciò produce una sorta di schema, i cui punti di appoggio non è detto che debbano coincidere con l’inizio del verso (poiché il verso è obbligato ad arrivare al margine del foglio, la sua fine è sempre casuale rispetto al periodo), ma comunque condannato a continue e reiterate ripartenze. Si attua una serie di ripetizioni, dislocate in punti del verso sempre differenti, continuate e riprese in un andamento “ad anelli” che si rincorrono trasformandosi. Mentre vari altri testi della stessa raccolta si basano sullo schema “se”… “allora”, qui lo schema è leggermente diverso, del tipo “questo è (vero), se…”, trasformato nel corso del testo in “questo è (per)ché…”; ma pur sempre uno schema raziocinante, inopinatamente riempito in modo contrario alla logica. Nel suo commento, Alberto Casadei ipotizza che «l’elemento di connessione e di asseverazione, cioè il “se è vero”, sia usato in apparenza come rafforzativo del discorso, ma richieda invece una risposta negativa: proprio perché il tu non è vivo, come l’io arriva a dichiarare (peraltro solo in forma di litote) al v. 5, allora il mondo è vedovo, e non è vero che l’io cammina ancora, e in fondo non è vero nemmeno il mondo» (Casadei, 2011: 99).
Tanto più, qui, sovrapponendosi il motivo di un rapporto con un “tu”, quale ci aspetteremmo di trovare in una poesia d’amore e di perdita dell’oggetto amato: senonché, questo tema tradizionalissimo in lirica sembra venir messo davvero al contrario. La frase ritornante «Tutto il mondo è vedovo», indica immediatamente uno stato universale di vedovanza, e però, questa “mancanza globale” è motivata esattamente al contrario di come ci si potrebbe aspettare: la versione plausibile sarebbe “il mondo è vedovo se tu non ci sei più”, invece è il fatto che «tu cammini ancora» a rendere privativa l’esistenza. Si potrebbe riflettere che non si tratta di “esserci”, ma di “camminare” e quindi questo potrebbe diventare (cammina, cammina, ci si allontana…) la causa di una mancanza. Tuttavia la mia impressione è che piuttosto la Rosselli voglia rovesciare come un guanto i rapporti tra positivo e negativo: «tu cammini ancora» e quindi il mondo dovrebbe essere felice, invece è miseramente luttuoso!
I passaggi successivi non sono meno anti-logici. «Tutto il mondo / è vero se è vero» tiene molto della tautologia; «tutto il mondo è vedovo se tu non muori» sembra pervenire nei dipressi dell’ossimoro (e sembra proprio aver gettato lì quel “non” come una sorta di lapsus). Troviamo poi una variante che fa finalmente quadrare il senso, o almeno sembrerebbe: «Tutto il mondo / è mio se è vero che tu non sei vivo», dove si arriverebbe a un tale punto di antagonismo che (o io o tu) solo l’estinzione fa dell’intero mondo una proprietà del soggetto, quasi il dualismo fosse un ostacolo che andasse rimosso. E però tutto ancora si ribalta, perché quel negativo (e proprio necativo) tuttavia positivo, si trasforma di nuovo e il “tu” prende il ruolo di guida, e pure luminosa (una «lanterna»), e quindi resterebbe, sebbene perduto, come un superego di riferimento. Il motivo della luce è accompagnato da quello degli occhi, che in questa prima comparsa sono tuttavia «obliqui», sfuggono, forse deragliano dallo stesso percorso assegnato loro. Ma ecco il rovesciarsi del positivo nel negativo: dagli occhi alla cecità. «Cieca rimasi», «cieca sono», la visione del soggetto è sbarrata ed è destinata a contagiare tutto l’universo, che diventa «cieco». Le congiunzioni ossimoriche si sprecano, a questo punto del testo: la «nascita» dell’altro (la nascita è esattamente un “venire alla luce”) coincide con la cecità dell’io; il «nuovo giorno» coincide con la «notte»; nella immagine finale, sono ancora gli occhi, divenuti molto grandi, forse anch’essi come lanterne, a occupare l’intera scena, mentre recano il “tu” «aggrappato» («ancora aggrappato ai miei occhi celestiali») e al contempo ancora camminante, per oltraggio alla verosimiglianza (come si fa a camminare aggrappati a degli occhi?). A parte l’elemento autobiografico, investito però di una valenza fin troppo sublimante (gli occhi celesti di Amelia, divenuti “celestiali”, paradisiaci, in un testo che addensa alquante inquietudini), bisognerebbe soppesare per bene quell’“aggrapparsi”: positivo, se il “tu” (o il suo ricordo) restano comunque negli occhi; negativo se indicasse un tentativo disperato di non essere abbandonato, oppure una malevola volontà di danneggiamento. Ovviamente l’ambiguità è indecidibile e voluta.
Ma, ecco il punto: quale allegoria? Effettivamente il testo di Amelia Rosselli non sembrerebbe attraversato da alcuna esplicita intenzione di sovrasenso. Semmai spicca in primo piano la difficoltà del senso, la sua problematicità o, se si vuole, instabilità o liquidità. E, nello stesso tempo, la contraddizione. Infatti, l’assetto è quello dell’apostrofe, questo è inequivocabile: può darsi che il “tu” sia perduto, che sia scomparso, addirittura defunto, rimasto nello sguardo come un’immagine, quello che non viene mai messo in dubbio è che sia dotato di ascolto, in quanto la parola è rivolta a lui e non ad altri, non viene mai trasformato in un “egli”, tanto che – formalmente – noi lettori non siamo che gli spettatori esterni di un dialogo che non ci riguarda. Certamente, però, le ripetizioni – quelle che potremmo chiamare le battute ritmiche – ci suggeriscono le due direttrici della “vedovanza” e della “cecità”. La poesia parla di un “mondo vedovo”, cioè svuotato di significato e in qualche modo privo di referente, in quanto la referenza sorge soltanto dalla allocuzione che la chiama ad esistere. E parla di un “mondo cieco”, dove per l’appunto ogni raffigurazione è condannata a rovesciarsi nel contrario. Non per niente, Casadei suggerisce che si tratti «di una cecità probabilmente allegorica» (Casadei, 2011: 99).
Insomma, il grande tema romantico di visione e cecità (nel Novecento messo alla base teorica della decostruzione di de Man), si applica in questa poesia di Amelia Rosselli non più come prerogativa di un atteggiamento sopraumano o del destino del genio, ma come l’esito di una assoluta convertibilità del linguaggio che, nel mentre si appoggia su modelli sintattici insistiti, non trova però il modo di conservare la propria isotopia semantica, senza vederla ad oscillare nel rimbalzo continuo delle antitesi.
5.
Un ultimo caso tra i tanti possibili lo traggo dalla poesia di Paolo Volponi. Ho detto sopra che l’allegoria moderna è anche il portato del fallimento storico. Le epoche “progressive” producono più facilmente realismo che allegoria, sono invece le epoche di crisi che usano come segni le cose che hanno perduto il senso. Si può spiegare così anche il ritardo volponiano rispetto alla stagione dello sperimentalismo: infatti la poesia più “anomala” dell’autore arriva – almeno quanto alle edizioni – quando i giochi sembrano fatti: Con testo a fronte esce nel 1986, del 1990 è Nel silenzio campale. Arriva quando c’è già il postmoderno e anzi la sua carica eversiva è proprio la reazione a un periodo di apparente pacificazione e mancanza di alternativa. Dopo il rientro della lotta di classe (che Volponi ha vissuto da dentro il sistema industriale, come testimoniano Le mosche del capitale), quali colpi restano da sparare alla poesia? Questa protesta, per certi versi improbabile, viene affidata all’incalzare del verso e al procedimento diffuso della rima ossessiva.
Introducendo Nel silenzio campale, Filippo Bettini ha sottolineato il legame con l’allegoria: «Una realtà prepotente come quella della barbarie industriale e delle sue manifestazioni di vuoto e di caos era aggredita […] con uno stile allegorico di assoluta tensione, insieme vario e concentrato, compatto e polivalente, ai limiti di un “neoespressionismo” travolgente, nutrito di umore, di ethos e di pensiero». (Volponi, 1990: 7) (6) Fin dal titolo della raccolta il silenzio campale rimanda a un combattimento mal sopito. Ma vediamo, in particolare, Tormenta: .
.
La notte resta fissa, attenta
alle mie mosse; accesa o spenta
una stella sul capo, scossa una cruenta
schiuma dai polsi, ritirata una lenta
rete di lame, lanciatasi come contenta
una sciarpetta sulle spalle di virulenta
nuvola di confine, lieta come chi inventa
mirando ai pozzi, intanto che scaraventa
tutto di sé, la stessa che lo spaventa
ultima e prima stretta, che non s’allenta
nemmeno scagliata via, contro le fondamenta
stesse della sua propria notte: trenta
volte ormai malamente redenta
persa ormai nell’intangibile intenta
voglia di respingere un luogo, che non veda e non senta,
che sprofondi colui che tenta
con quel suo piccolo nirvana un campo e una sementa
sua propria che di luce arroventa
oltre le strade, l’ordine, l’argomenta,
con una verde pupilla che alimenta
un disco inafferrabile, diverso, una tormenta
aliena, di fera combustione anche se spenta.
.
È fin troppo facile attribuire alla tormenta una significazione allegorica riguardante il momento storico che vede la difficoltà e quasi l’annientamento dell’utopia. In più, però, insieme alla tempesta di neve, compare all’inizio del componimento la “notte”, personificata, si direbbe, quasi come una belva in agguato, certamente come una forza oppressiva in atto di sorveglianza («attenta alle mie mosse») e pronta ad azioni di contrasto ad ogni deviazione («che sprofondi colui che tenta»…). La notte è anche il nodo che tiene insieme la regressione storica generale e i problemi individuali (il tema dell’insonnia che percorre la poesia volponiana) e il personale-corporeo, agendo qui sul capo, i polsi, le spalle, ecc. La tormenta è detta “aliena” e dunque è alienante, è l’alienazione stessa; e l’ultimo verso (la «fera combustione anche se spenta») passando dalla vessazione del freddo a quella del fuoco che ormai è divampato, contiene in modo forte l’aggressività del “silenzio campale”. Non ci sarebbe bisogno di rimarcare lo spegnimento della combustione, se non ci fossero ancora delle scintille sotto la cenere, se l’utopia negata dalla realtà non costituisse un insopprimibile sollecito alla carica espressiva.
E c’è dell’altro. L’interpretazione allegorica non può trascurare come il testo è scritto. Incontriamo qui un caso evidente di “allegoria della forma”. Sono infatti estremamente significativi i due procedimenti determinanti, vale a dire la rima insistita (qui addirittura portata a coprire l’intero testo con un’unica terminazione in -enta, compreso il titolo) e l’enjambement, anch’esso praticamente totale, anche se due o tre versi gli sfuggono. (7) Anche in questo caso, s’incontra qualcosa che ha perso senso e quindi può assumerne un altro: la rima, vecchio procedimento principe della tradizione poetica, non ha più la sua fondamentale funzione d’ordine e non è più obbligatoria, anzi. Lasciar che ritorni e addirittura in questo modo esagerato, diventa in Volponi una coazione a ripetere che ha a che fare con l’automatismo: all’alienazione personificata si aggiunge questa alienazione in forma sonora. Quanto all’enjambement, sembrerebbe operare al contrario: in quanto spezzatura del discorso rompe il flusso e rappresenta una forma di ripresa, per così dire, indomita. La rima dice il sempre uguale, l’enjambement “ma non finisce qui”. Ma a ben vedere anche la rima è ambivalente, perché non ha più nulla della regolarità circolare classica (per dire, della quartina o del sonetto); la rima reiterata indica chiusura e immediata riapertura, la sua durata si prolunga all’estremo possibile e quindi funziona anch’essa a sottolineare una tensione incontrollabile.
6.
Per concludere, due osservazioni. La prima, molto veloce, riguarda l’uso che ho fatto del termine allegorismo invece che propriamente allegoria. Infatti, l’allegoria moderna sembra più libera di percorrere varie strade, finendo quasi per identificarsi con la sperimentazione. Per questo, invece di circoscrivere una forma in coordinate determinate è meglio parlare di un’azione sulle forme, di un’allegorizzazione, di un allegorismo.
La seconda osservazione riguarda l’impressione che può aver dato la connessione dell’allegoria moderna con il negativo, la crisi, il fallimento. Insomma, “mai ’na gioia”: commissioneremo all’arte e alla poesia l’espressione di un pessimismo totale? La risposta potrebbe essere che è sempre meglio avere «la conscience dans le Mal», come dice L’irrémediable di Baudelaire. Ma si può anche ipotizzare una più complessa dialettica. Walter Benjamin, nelle pagine finali del suo libro sul dramma barocco, indica un simile testa-coda degli estremi. L’allegoria è connessa al male: «Nelle astrazioni vive l’allegorico, e in quanto astrazione, in quanto facoltà dello stesso spirito linguistico, esso ha la sua dimora nel peccato» (Benjamin, 1971: 255); eppure, proprio il suo carattere deviante (il “dire altro”) fa sì che il male stesso, una volta coinvolto nell’allegoria, significhi «il non essere di ciò che rappresenta», fino al ribaltamento «in quanto inferno, dentro l’onnipotenza divina»: «Nel male Tout court la soggettività attinge la sua realtà e la vede come un mero rispecchiamento di se stessa in Dio». (Benjamin, 1971: 255-256) Se il male della storia svuota le cose di valore, il nuovo significato allegorico le riabilita. Ciò che nel Dramma barocco Benjamin dice in termini “teologici”, può essere ridetto (e lo stesso Benjamin lo farà in seguito) in termini laici attraverso una “rifunzionalizzazione” della scrittura che è un indice di utopia.
Così fa lo stesso Juan Carlos Rodríguez, proprio in margine al commento di Montale già ricordato sopra. La scoperta del nulla è difficile da sopportare, ma può essere volta rigorosamente verso un rovesciamento politico:
“Y esto es bellísimo: la vida se construye a partir del vacío de la plenitud histórica, de la nada en las espaldas. Así se sigue viviendo: a partir del vacío. Puesto que los hombres sólo nacen para «vender su vida» (somos «vidas vendidas» desde el nacimiento), el vacío y la nada son nuestro sentido-límite. Y como eso conlleva miles de contradicciones, nosotros (y nuestros discursos y nuestra literatura) tratamos de luchar contra eso diciendo no a la venta y diciendo sí a un futuro que está ya aquí, delante y en el interior, como en el poema de Montale, una segunda lengua a la que atisbamos apenas como libertad sin explotación o sin venta“. (Rodríguez, 2002: 55-56)
Certo, come ha scritto una volta Jameson, «Allegoria e comunismo rappresentano due insoliti compagni di letto» (Jameson, 1975: 134). Ora, dei due strange bedfellows, mentre la prima ha ripreso a circolare anche troppo, il secondo è sparito dai radar e si presenta solo in qualche malcelata nostalgia (in negativo o controluce, come abbiamo visto in Volponi). Eppure, l’allegoria indica sempre qualcosa d’altro “fuori di sé”. Non è solo questione di scoprire “cosa vuol dire?”, ma la domanda del senso deve includere anche la direzione, la “giusta tendenza” e non solo quella letteraria.
(1) Una riflessione che è continuata anche nel successivo libro su Benjamin, Dossier Benjamin (Jameson 2022).
(2) Vedi, in appendice al volume, l’importante allegato intitolato The Greimas Square.
(3) «L’allegoria consiste nel sottrarre a una data rappresentazione l’autosufficienza del significato […] ma più spesso, e soprattutto in tempi moderni, l’allegoria assume la forma di un piccolo cuneo o di un’apertura posti accanto alla rappresentazione, che può continuare a significare se stessa e a sembrare coerente. […] Anche se questo “stare per” di solito è considerato realistico, nondimeno una distanza allegorica, davvero minima, si apre all’interno dell’opera: una breccia attraverso la quale significati di tutti i tipi possono infiltrarsi uno dopo l’altro. L’allegoria è così una ferita rovesciata, una ferita nel testo; essa può essere tamponata o tenuta sotto controllo (in particolar modo grazie a un’estetica attentamente realistica), ma mai del tutto eliminata come possibilità» (Jameson 2008: 162).
(4) È un verso di Poesia facile, che segue l’inversione di Petrarca («Pace non cerco, guerra non sopporto»).
(5) In questo caso addirittura con la metonimia del “lavoro” al posto dei “lavoratori”.
(6) Di «scrittura allegorica» ha parlato anche Aldo Mastropasqua (Mastropasqua 2021: 134).
(7) Una interessante analisi metrica è in Mastropasqua 2021: 127.
Riferimenti bibliografici:
Benjamin, W. (1971): Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi.
Bettini, F. (1990): “Introduzione”, P. Volponi, Nel silenzio campale, Lecce, Manni.
Campana, D. (1973): Opere e contributi (vol. 2), Firenze, Vallecchi.
Campana, D. (1985): Canti orfici, Firenze, Vallecchi.
Carlino, M. (2008): Dodici osservati speciali, Roma, Bulzoni.
Casadei, A. (2011): Poetiche della creatività, Milano, Bruno Mondadori.
Jameson, F. (1975): Marxismo e forma, Napoli, Liguori.
Jameson, F. (2008): Brecht e il metodo, Napoli, Cronopio.
Jameson, F. (2019): Allegory and Ideology, Londra-New York, Verso.
Jameson, F. (2022): Dossier Benjamin, Roma, Treccani.
Lukács, G. (1978): Scritti sul realismo, Torino, Einaudi.
Mastropasqua, A. (2021): Opposizione e ricerca, Roma, Lithos.
Montale, E. (1980): L’opera in versi, Torino, Einaudi.
Rodríguez, J. C. (2002): De qué hablamos cuando hablamos de literatura, Granada, Comares.
Rosselli, A. (2012): L’opera poetica, Milano, Mondadori.
Scrimieri, R. (1996): Introducción a E. Montale, 37 poemas, Madrid, Hiperión.
Zambon, F. (2021): Allegoria, Roma, Carocci.
Per scaricare il pdf clicca qui.
Foto di Francesca Coldebella Bergamin.

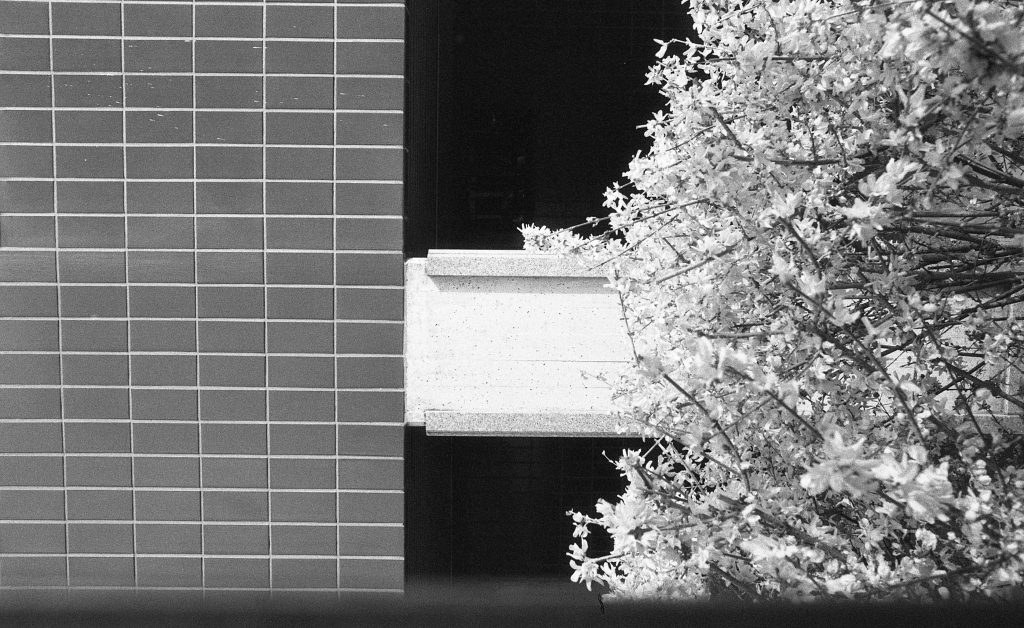



Lascia un commento