La raccolta di esordio di Agnese Fabbri s’intitola Stagioni (Interno Libri, 2022) e le stagioni danno il nome anche alle quattro parti (Primavera, Estate, Autunno, Inverno) di cui si compone il libro. Ognuna di esse contiene sette poesie in romagnolo titolate, ma questo gruppo è sempre preceduto da un testo in italiano privo di titolo che sembra continuare una riflessione precedente; si tratta di un procedimento ben visibile nella primissima lirica della raccolta:
.
Mi ricordavo,
infine, della pioggia che era scesa,
delle piante salvate dall’inverno.
Le case che si aprivano e il ritorno,
lento, dei fantasmi. Di quando tutti,
ogni giorno, ci sediamo a tavola
e proviamo con forza a ritrovare
le cose perse del mattino.
.
Rimandano qui a qualche cosa di precedente e non immediatamente esplicitato al lettore quantomeno parole come ‘infine’, ‘inverno’, ‘ritorno’, ‘fantasmi’, ‘ritrovare’ e ‘perse’, quasi che il primo testo si voglia dichiarare non (solo) come apertura, ma anche prosecuzione.
In questo libro, in effetti, esiste un’idea di tempo eterno e circolare che è insita all’alternarsi delle stagioni: come si è visto, il primo testo della prima sezione – Primavera – cita il precedente inverno – nome della sezione che chiude la raccolta – e “infine” lo ricorda, ma qualcosa di simile accade in Un cino / Un film, dove davanti a chi si siede su un divano abbandonato in un campo scorrono «òna dri ’ cl’êtra, / al staṣon, al ca, i tadesch» («una dopo l’altra / le stagioni, le case, i tedeschi») e, se ci si chiede cosa fare dopo un tale spettacolo, si contempla con ugual peso la possibilità di portare fiori «ins al tòmbi in do ch’a sen ẓa stêdi, / o impinì i sicȋ e ẓughê, /coma do tabachi» («nelle tombe dove siamo già state, / o riempire i secchielli e giocare, / come due bambine»); ancora, in Caminê / Camminare nelle chiese di montagna «U j è mi nöna, / e la nöna d’mi nöna, / e toti al dön ch’va in ciṣa, / cun e’ fazulet int la tësta, / e’ ruṣêri int al mân, / e la gvëra par d’dri» («c’è mia nonna / e la nonna di mia nonna / e tutte le donne che vanno in chiesa, / con il fazzoletto in testa, / il rosario in mano, / e la guerra alle spalle»), e comunque «l’è sëmpar al dò de’ docmaẓdè» («sono sempre le due di pomeriggio»); in E’ mònd / Il mondo, «Un pô a la vôlta al staṣon al tórna in dri» («un po’ alla volta, le stagioni tornano indietro»); in L’os / La porta «a n’so piò s’a so sëmpar me, / o s’a so me da tabaca / ch’a fëgh cont d’resar grân̄da» («non so più se sono sempre io / o se sono io bambina / che fingo di essere grande»); in Serpent / Serpenti, l’ultima lirica della raccolta, l’ultimo verso riprende la prima poesia nel dire che «e’ taca a pióvar» («inizia a piovere»), legando inizio e fine in una struttura ad anello.
Questa ciclicità, tuttavia, convive con la linearità della lettura: da questo punto di vista, il primo testo sembra dirci che Stagioni è nata “in-fine” ad un periodo di oblio, quasi che, non appena alla dimenticanza è sopraggiunto il ricordo, si sia reso necessario agire sulla base di quanto si è rammentato e strapparlo per sempre a futuri oblii attraverso la poesia.
Una poesia che salva ciò che si è salvato da sé, dunque, una celebrazione di ciò che era perso ed è stato ritrovato. Più precisamente, questo relitto sembra legarsi all’ambito familiare e ad un’idea di nostos verso la patria perduta. Pertanto, se stupisce l’estrema maturità della lingua d’esordio, non stupisce, invece, ritrovare nella raccolta figure di archetipica eternità magistralmente umanizzate: è così la madre in I fil / I fili che lascia alla figlia fili (i rapporti umani) appesi ai rami degli alberi, lei che «la i tnéva da cont par cuṣì» («li teneva da conto per cucire») quando l’io lirico afferma «a i druv pr arcurdêm dla pavira» («li uso per ricordarmi della paviera»), ossia un’erba palustre che veniva lavorata nel paese natale di Fabbri; così anche la nonna che in Tciota dla tetöia / Sotto la tettoia offre la comprensione senza giudizio di chi sa di non poter capire, mentre Agnese si chiede «coma t’fé a nö pinsê / ch’a so una döna, / nenca me, ch’a so strâmba» («come fai a non pensare / che sono una donna, / anche io, che sono strana» per quanto poi sappia che si sarebbe sentita rispondere «d’metm in ṣdé e d’stê un pô bona, / ch’u s’arimigia ignacvël, / che ’t ignamôd / me a so ẓóvna e te tci vëcia» («di mettermi a sedere e stare tranquilla / perché tutto si sistema / e che comunque / io sono giovane e tu sei vecchia»); come, infine, i morti nel cimitero in J è tot a cve / Sono tutti qui, che non hanno fretta come chi è vivo, e «I ten d’astê ch’a m’dreza, / coma ch’aves da cminzê / a ẓirê adës» «aspettano che mi alzi in piedi / come se dovessi imparare / a camminare ora».
Il gesto di camminare, poi, appare collegato intimamente alla scrittura. Entrambe le azioni prevedono un percorso di allontanamento da se stessi per ritrovarsi, come in E’ sêl / Il sale «Cvânt ch’a n’so piò in do ch’a so a camen̄ / […] E cun piò ch’a végh luntân, / cun piò ch’a so in do ch’a stëgh. / Sól cvânt ch’a so ’riva d’cô / u m’ven int la ment com ch’u s’fa a andês a ca» («Quando non so più dove sono cammino / […] E più vado lontano, / più so dove abito. / Solo quando sono arrivata in fondo / mi ricordo come si fa a tornare a casa»). Ne consegue necessariamente l’uso del romagnolo, visto che la lingua minoritaria è per eccellenza linguaggio-rimosso, tanto più nel caso dell’autrice. Infatti, come ci informa Giuseppe Bellosi nella prefazione: «Agnese il dialetto non lo parla […] lo ascoltava dalle voci dei genitori, dei nonni, dei compaesani. Agnese il dialetto non lo parla. Ma lo sa». La lingua negata nella crescita che ineluttabile riaffiora diventa una delle «piante salvate dall’inverno» e, con essa, viene salvato e portato a vivere anche l’altrettanto negato io che avrebbe potuto parlare il romagnolo in casa, sentendosi così più intimamente parte del contesto familiare e locale. Cantando, cioè, tutto ciò che ha resistito all’oblio si salva anche una parte di noi da cui eravamo lontani (tanto che, forse, non c’è mai stata) e ritroviamo il nostro posto nel mondo.
Per scaricare il pdf clicca qui.
Foto di Francesca Coldebella Bergamin.

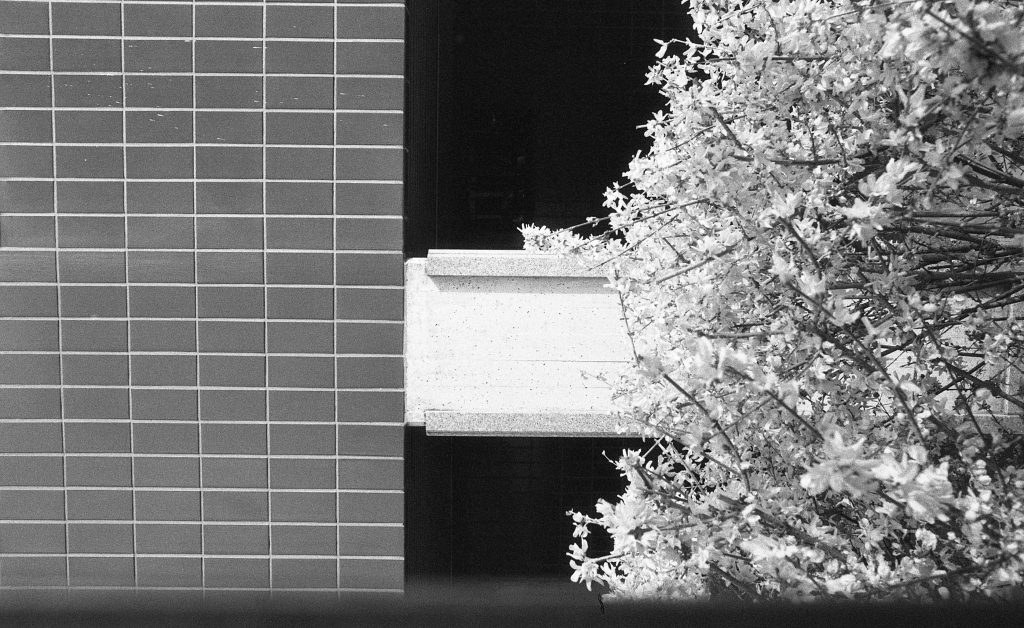



Lascia un commento