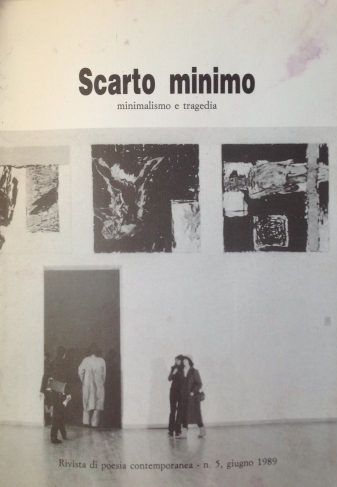da “Scarto minimo”, n. 5, giugno 1989.
*
*
Quel che è ora cagione a te di tanta tristezza avrebbe potuto esserlo piuttosto di tranquillità. Ti ha lasciato colei dalla quale nessuno potrà mai vivere sicuro di non essere abbandonato.
De Consolatione Philosophiae, detto della Fortuna
*
È solo quando mi accorgo che le avversità a cui vado incontro o che mi procuro per passare il tempo non riescono ad intaccare la mia potenza umana, ma anzi la amplificano dandomi la facoltà, irripetibile ogni volta, di capire di più, di toccare con mano la mia essenza e la mia libertà, è solo quando succede questo che sono felice. Le piccole gioie della vita non bastano. Non c’è totalità nella gioia di primo grado, al positivo, perché per romperla basta un nulla: qualsiasi cosa può turbarla e il futuro la spaventa.
Io credo che ci sia un livello superiore di esistenza, che scatta nel momento in cui non ho niente da perdere. A questo livello è possibile una esperienza di totalità che comprenda anche altri tempi oltre a quello presente.
Ma è nel momento in cui attingo a questa felicità totale, anzi nel momento in cui essa si perpetua in me, si nutre di sé e della sua coscienza, nel momento in cui potrebbe gratificarmi, che nasce la tragedia, che è sempre impossibilità e che in questo caso è impossibilità di soffrire.
Sarebbe facile ascrivere comunque questo discorso ad un’istanza di tipo narcisistico, ma credo che ciò sia incompatibile con un autentico stato tragico. Il limite tra felicità e narcisismo sta qui: da una parte una felicità cieca, che ha semplicemente incanalato il negativo su binari controllabili, dall’altra una rottura consapevole dei binari, una mancanza di controllo che determina la tragedia di una felicità che non basta a se stessa. L’importante è non recitare, mentre si rivela chiaramente il semplicismo astioso di massime come quella di Milosz: «Al savio in sorte l’infelicità, allo stolto la gioia avvelenata». In realtà si oscilla tra felicità e sofferenza, dove la felicità è uno stato ottenuto attraverso un sentimento del nulla, e la sofferenza è ciò che resta di questo nulla, il suo nocciolo duro, eliminabile forse, ma a scapito della nostra umanità. Perché la sofferenza è ciò che ci lega alla terra. E’ una fortuna e una sfortuna: tutto ciò che è dolorosamente umano ci può fare felici, ma non ci è permesso di attingere a fonti diverse dalle umane. «Tutto quanto compiremo d’ora in poi d’essenziale, lo compiremo in mancanza di meglio. Senza contentezza né disperazione» (R. Char).
Vorrei provare a immaginare un piacere del dolore. Una gioia non affrontabile dalla misera psicologia nei termini di un masochismo, in una prospettiva che non miri al benessere, ma al bene. Ad una introspezione psicologica risulta difficile rendere conto di una dimensione spirituale.
Forse non è perché sto male che a volte provo l’impulso di ficcare la testa in un tombino. So che potrei provare questo in qualunque momento, anche in un colmo di pacificazione con me e con il mondo. Viceversa la sensazione di un vivere pieno, che forse è felicità, non mi coglie necessariamente nei momenti di benessere. C’è qualcosa di più vero del mio star bene e del mio star male, e per avvicinarmi ad una definizione di questa cosa mi è vietato lo strumento dell’introspezione, almeno di quel genere di introspezione che per esercitarsi si serve della rete di rapporti che ho intrattenuto e intrattengo con il mondo. Ma esiste un’introspezione pura, non avente a che fare con l’esterno? Ogni distinzione fra Io e mondo sarebbe impertinente, dilatandosi la dimensione soggettiva fino a comprendere tutto. Sarebbe il momento dell’Io-mondo, dove la poesia è di casa.
C’è una vita che mi guarda e che non è me stesso. Una cosa enorme che esiste al di fuori di me e che io continuamente cercavo di capire, di rendere interna a me, di inglobare nell’Io. Questa tensione all’incameramento dell’universo nel corpo si trova spesso in poesia. Nella prospettiva più radicale non ci sarebbe alcuna Visione del Mondo perché non avrebbe luogo alcuna scissione fra il mondo e il soggetto che vive. Di qui le varie poetiche tragiche, le ferite aperte, le piaghe languenti e via dicendo.
Ma c’è un’altra possibilità: quella in cui le varie individualità guardanti nel loro tentativo fagocitante e il mondo esterno venissero a loro volta guardati da un Io-mondo di ordine superiore. Non interessa rilevare l’hegelismo lampante di tale assunto iperteorico. Ciò che conta è che il «soggetto maggiore» che riuscisse a fare questo avrebbe raggiunto un livello di adesione alla vita tale che essa potrebbe svolgersi in piena libertà dalle costrizioni dell’«Io minore», solo per lui determinando tragedie e felicità in eccesso d’umano, solo per la sua ansia fagocitante.
La pulizia sarebbe la caratteristica dominante di questa visione dall’alto il cui esito – di rilevanza non indifferente – sarebbe forse di poter giungere ai limiti estremi delle possibilità di rappresentazione del linguaggio. Sarebbe una visione pura, saltando a pié pari la psicologia e ogni forma di attaccamento. Il dolore e la gioia godrebbero del loro giusto peso fra noi, favorendo il nostro ritorno al mondo, ma con altro animo. Come sarebbe bello e diverso allora ricominciare i rapporti, la socialità, la politica.
Uno dei nodi fondamentali per una poesia che voglia ritornare al mondo è quello di una riconsiderazione dei rapporti fra maschera e verità.
Il culto della verità si esplica attraverso una a-metaforicità antiretorica. Si instaura un apparato antiletterario, si elimina la finzione al fine di comunicare un’essenza… liberarla dalle mistificazioni, dalle sovrastrutture soffocanti della lingua. Ma poiché l’essenza, se è tale, non può comunque essere rappresentata da una lingua, pena la perdita di autenticità, sulla forma della verità si proietta l’ombra frastornante del confessionale: un’amplificazione delle occorrenze del discorso con esiti mistificatòri. Un soffocamento del vero stesso ad opera di una esibita sincerità. D’altra parte l’assunzione tout court di un mascheramento esplicito, di una ostentata inautenticità o esteriorità, con l’intento di servire in tal modo più fedelmente la causa della verità, lascia un po’ perplessi per il ritegno che la contraddistingue. Troppo lontano da una nominazione, che rimane l’unico atteggiamento in grado di scuoterci.
Ciò che ci potrebbe rappresentare più adeguatamente non è una verità-confessione, né il suo rovesciamento «a fin di bene», ma una liberazione dal senso di questa ricerca del vero e dal suo contrario. Non la sincerità coatta né la maschera che allontana: forse il vero limite è quello dell’insensatezza e forse solo la folle varietà della nostra morte può valere la pena di essere vissuta. Vissuta: non capita né confessata, né tantomeno metaforizzata. Non dovrebbe mai esserci un vuoto che parla, né un troppo pieno… ma una persona e la sua, singolare e collettiva, verità.
La tensione confessionale alla verità, nella misura in cui si serve di uno stile il più comune possibile, appartiene alla grande famiglia delle estetiche del brutto, quelle che rifiutano la retorica del bello scrivere. Quest’ultima è invece sottesa, in modo più o meno pesante, ad ogni scrittura allontanante, proprio perché nell’intento di fuggire la nominazione si è quasi sempre costretti a ricorrere a un apparato metaforico o comunque ornamentale.
La trasgressione, si sa, rimanda troppo al suo oggetto. È così che su di un altro versante il problema non dovrebbe essere quello del bello e del brutto, ma quello di liberarsi dal senso di bello e di brutto. Non si tratta di parteggiare per l’una o l’altra estetica, ma della possibilità di crearne una terza: un’estetica dell’indifferenza, che non sia una via di mezzo fra le due, né la loro sintesi più o meno dialettica, ma proprio un’altra cosa. Ancora, non un’indifferenza alla forma (prospettiva allettantissima ma che, oltre ad essere passibile di confessionalità, mi sembra servirebbe solo ad avvallare delle brutture, senza peraltro apportare alcun guadagno in valore), ma una forma che sia indifferenza. E poi «indifferenza», non insensibilità al dolore che si avverte in una percezione estetica piena. Questo dolore va salvaguardato perché è il cuore pulsante di tutte le grandi poesie.
Nella forma della poesia rimane quindi un segreto che non bisogna confondere con un facile gusto per il non detto. Non credo che ci sia un segreto da preservare. Ci può essere invece un dire la propria vita che non sia confessione, ma un essere nella sincerità. La vita non viene confessata, viene semplicemente detta a chi la vuol sentire. L’apparente reticenza non è dovuta ad una volontà di mascheramento, ma alla necessaria priorità della forma. Tale priorità non può essere considerata in questo caso come una fuga dalla semplice verità dell’esistenza, ma come l’unica valida difesa dal banale e dagli attacchi della doxa. Ciò che è comune non ha niente a che fare col banale. La mia verità ha valore solo nel momento in cui si fa comune, ma non c’è una verità comune preesistente alla mia, e se c’è è annacquata e stravolta nell’essenza, nell’adeguarsi al vivere concreto di ciascuno.